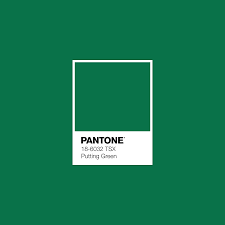Da quando ha avuto inizio l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus il mondo della psicoterapia ha dovuto prendere, come in ogni situazione di crisi, decisioni drastiche e rapide. E così psicologi e psicoterapeuti di ogni età, e scuola di pensiero hanno montato la sirena sulla cappotta della propria professione per continuare a guidare le sedute in stato di emergenza. Da settimane i media ci mostrano le immagini molto evocative delle città di tutto il mondo in una surreale condizione di silenziosa desolazione. L’obiettivo di una professione clinica, quale è la psicologia, è dare il suo contributo affinché tale desolazione del mondo esterno non vada a coinvolgere anche gli stati interni, ora più che mai vulnerabili, di tutti quanti noi. Tutti nessuno escluso, nemmeno di chi vuole fare della promozione del benessere e della salute il proprio mestiere. Perché da questa inedita situazione di emergenza globale, nessuno ad oggi può sentirsi invulnerabile oppure pronto e adeguato ad affrontarla. Non lo sono i medici e gli infermieri, e men che meno lo possono essere gli psicoterapeuti.
A partire da riflessioni simili nasce questo articolo che ho voluto chiamare “i dolori del giovane terapeuta”, senza celare una velata nota autobiografica. Perché la verità è che anche la vita del terapeuta, più o meno giovane, è dolorante e costretta in questi giorni a fare i conti con le angosce di questo trauma collettivo e con le paure e le incertezze che il virus porta con sé. E perciò trovo sconveniente le lezioni di vita in tal senso perché la più autentica (e perché no) terapeutica condotta da tenere, anche verso i propri pazienti, è continuare a dimostrarci professionali e al contempo adeguatamente inadeguati. Dietro a questo, solo apparente, ossimoro si fondano le basi del rapporto tra psicoterapeuta e paziente, in questo particolare momento storico. Le terapie non possono proseguire, o iniziare, come se nulla stesse accadendo. Il giovane (e anche il meno giovane) terapeuta non è Clark Kent e nella sua dichiarazione di adeguata inadeguatezza risiede tutta l’autenticità della relazione terapeutica, chiave di volta di ogni efficace percorso di cura. Ben venga quindi la conduzione dei colloqui on-line ma sono, riprendendo l’immagine che ho usato prima, interventi con la sirena. E il rumore della sirena si fa sentire perché il giovane (e meno giovane) terapeuta è costretto a fare di necessità virtù, e lavorare al di fuori del proprio studio tra le mura di casa in una condizione del tutto nuova del tutto inedita ed assordante sia per chi la pratica sia per chi la riceve.
Al giovane (e meno giovane) terapeuta manca il suo studio nel quale si è consolidata e creata la relazione autentica col paziente che ora, seppur in modo altrettanto autentico, è sfumata dal filtro che crea lo schermo del computer o del tablet nelle sedute on line.
“Questa o quella per me pari sono” cantava il duca di Mantova nel Rigoletto di Giuseppe Verdi. Ma il giovane (e meno giovane) terapeuta non può far suo questo ritornello e non preferire il colloquio vis a vis rispetto a quello condotto attraverso una applicazione per tablet. Una volta finita questa situazione di emergenza è bene che paziente e terapeuta tornino a coltivare la propria relazione all’interno dello spazio protetto dello studio e non continuare on-line perché queste modalità, seppur entrambe efficaci, non sono e mai potranno essere una uguale all’altra.
In queste settimane così difficili il giovane (e forse anche il meno giovane) terapeuta ascolta, osserva e guarda i cambiamenti del mondo in cui vive. E come il resto della popolazione ha imparato ad utilizzare e convivere con termini nuovi quali picco, epidemia, autocertificazione, quarantena. E proprio quest’ultima parola si è andata svuotando del suo originario significato. Se per gli antichi essa indicava un periodo di digiuno ed espiazione, al contrario oggi la mastichiamo e mangiamo tutti i giorni. Sul web e nei social, tra un hashtag e l’altro, è forse la parola più digitata del momento. Ma al giovane terapeuta non piace utilizzarla con leggerezza e lascia ad altri il compito di illustrare i “consigli su cosa fare in quarantena”, “come affrontare la quarantena” e compagnia bella. La sua attenzione invece è focalizzata alle conseguenze emotive che questa pandemia già si sta portando appresso, ai vissuti interni che prendono forma nella parte più intima di ogni persona, ai lutti (più o meno grandi più o meno metaforici) che questa condizione di isolamento produce nella quotidianità. Perché il giovane terapeuta non vuole insegnare al paziente come essere produttivo, attivo, impegnato e svagato in questo momento tragico, ma sarebbe già un obiettivo di grande ambizione accettarsi e fare accettare la comune condizione di adeguata inadeguatezza.
Per concludere vorrei citare un pezzo dell’intervista dello psicoanalista Stefano Bolognini, del quale ho avuto il piacere di assistere negli anni ad alcune sue supervisioni, rilasciata pochi giorni fa alla rivista Psychiatry Online.
Lasciamo stare i proclami ottimistici, miglioristi, fideistici, che servono a raccontarcela in modo narcisistico e autocelebrativo (“saremo migliori”, “riscopriremo l’umanità e la fratellanza”, ecc)
[Quando tutto sarà finito] Però credo che si svilupperà almeno un po’ di maturità collettiva in più, alla fine, e un sano ridimensionamento delle illusioni, delle pretese narcisistiche e dell’onnipotenza imprevidente.
Probabilmente consumeremo con più criterio, viaggeremo un po’ meno freneticamente e ridimensioneremo almeno un po’ il bisogno dell’”altrove” compulsivo che caratterizza spesso la fuga da noi stessi.
Metteremo a fuoco con più realismo i nostri effettivi legami, affetti e investimenti; i nostri limiti, i nostri veri profili, che ci eravamo illusi di smentire in un tourbillon di onnipotenza favorito dalla tecnologia.
Saremo un po’ più consapevoli di quello che siamo.
NOTE
L’intervista integrale del professor Bolognini, della quale consiglio a tutti la lettura, è consultabile al seguente link:
http://www.psychiatryonline.it/node/8539